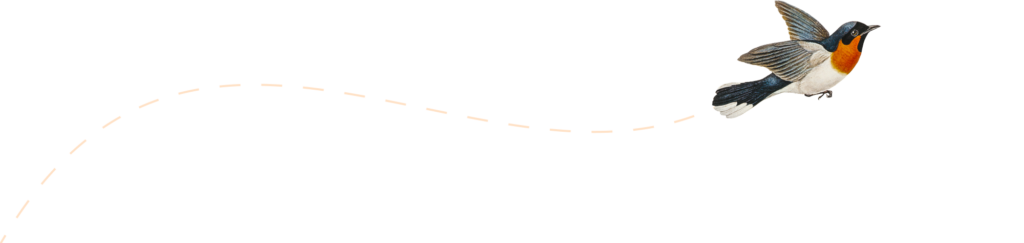A un seminario con dirigenti di imprese del settore agroalimentare abbiamo analizzato i piani di sviluppo in atto. Ne è emerso un quadro di passività e stasi, una sorta di rassegnata accettazione degli eventi commerciali e produttivi, come se questi fossero governati da disegni imperscrutabili ed incomprensibili. Chi lavora nel settore agroalimentare dà spesso per scontato che il futuro è imprevedibile, in quanto troppi elementi rendono difficile la pianificazione: gli andamenti climatici, le azioni dei concorrenti (sempre più globali), la legislazione e le politiche di sostegno e regolamentazione, i gusti del pubblico e le mode, le politiche di acquisto della grande distribuzione, e così via. A queste incertezze tipiche del settore, vanno poi aggiunte le preoccupazioni per la situazione di crisi attuale.
A un seminario con dirigenti di imprese del settore agroalimentare abbiamo analizzato i piani di sviluppo in atto. Ne è emerso un quadro di passività e stasi, una sorta di rassegnata accettazione degli eventi commerciali e produttivi, come se questi fossero governati da disegni imperscrutabili ed incomprensibili. Chi lavora nel settore agroalimentare dà spesso per scontato che il futuro è imprevedibile, in quanto troppi elementi rendono difficile la pianificazione: gli andamenti climatici, le azioni dei concorrenti (sempre più globali), la legislazione e le politiche di sostegno e regolamentazione, i gusti del pubblico e le mode, le politiche di acquisto della grande distribuzione, e così via. A queste incertezze tipiche del settore, vanno poi aggiunte le preoccupazioni per la situazione di crisi attuale.
Se quindi il futuro è imprevedibile, che senso ha impegnarsi ad elaborare piani di sviluppo? Se i cambiamenti ambientali e di contesto sono continui, spesso senza una logica lineare, vale la pena parlare di utilità della programmazione? In altri termini: è possibile pensare di poter gestire il futuro, di controllare il corso degli avvenimenti che riguardano la propria azienda? Ogni imprenditore e manager deve dare necessariamente una risposta a questa domanda.
Se è vero che gestire il futuro è impossibile, questo non significa che di fronte all’incertezza non valga la pena prepararsi ad essa. Innanzitutto occorre lavorare sulla propria organizzazione, in modo da renderla la più reattiva possibile, puntando sulla sua prontezza per rispondere in tempo reale ai cambiamenti, a mano a mano che questi si rendono necessari. Le imprese devono puntare sulla reattività e focalizzare i propri sforzi nel rendere sempre più snella la propria gestione operativa.
Contemporaneamente occorre mettere mano a piani di medio termine (3 anni), che definiscano il posizionamento aziendale rispetto ai mercati (di sbocco e di approvvigionamento). Tali piani dovrebbero cambiare radicalmente non di fronte alle prime difficoltà congiunturali, ma solo quando vi sono cambiamenti strutturali nel settore e nel mercato. Stiamo parlando di quei piani che indicano l’insieme delle scelte di fondo e delle azioni quotidiane a presidio della posizione competitiva dell’azienda. Ogni azienda, infatti, possiede una specifica ed inimitabile combinazione di fattori, dati dal modo di posizionarsi sui mercati di sbocco e di approvvigionamento, dai suoi obiettivi di quota di mercato, dalle sue competenze, dalle sue relazioni coi fornitori di capitale, dalla sua modalità di gestire il personale. L’insieme di questi fattori costituisce l’identità strategica dell’azienda. Un piano aziendale deve spiegare il perché uno specifico sistema di posizionamento dovrebbe produrre i migliori risultati. La qualità di un piano di sviluppo dipende dalla coerenza fra le proprietà specifiche dell’azienda (know how posseduto e risorse controllate) e le logiche che governano i mercati di sbocco e approvvigionamento.
Si tratta quindi di passare dallo strategic planning allo strategic thinking. È tutta l’azienda che è continuamente allerta; tutti sono tesi a cogliere i segnali di cambiamento ancor prima che questi diventino visibili. Gli strumenti analitici e concettuali di tipo strategico devono essere bagaglio di molti e non di pochi; la cultura aziendale deve essere propensa ad accettare la sperimentazione come forma di prova di strategie nuove. Più persone devono essere impegnate a fare strategia, e a farla più spesso. Occorre quindi guardarsi da tentazioni troppo verticistiche che attribuiscono al top management virtù taumaturgiche non corrispondenti alla realtà.