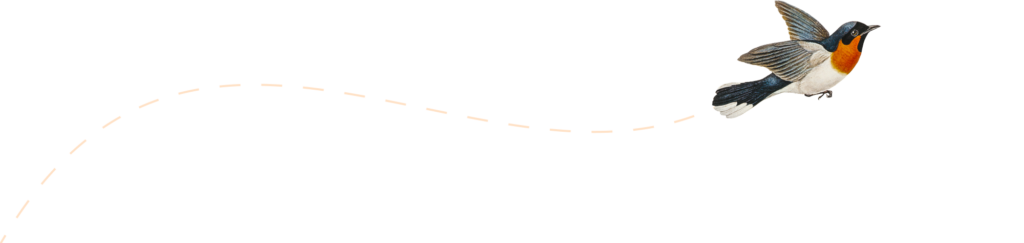“Se non siete capaci, senza aiuto, di usare i servizi igienici, mangiare, vestirvi, lavarvi, controllare gli sfinteri e spostarvi – le sei «attività quotidiane di base» – allora non avete i requisiti basici per l’autosufficienza fisica. Se da soli non riuscite a fare la spesa, prepararvi i pasti, tenere in ordine la casa, fare il bucato, prendere le medicine, usare il telefono, spostarvi con i mezzi di trasporto e maneggiare i soldi – le otto «attività strumentali della vita quotidiana» – allora vi manca la capacità di vivere per conto vostro in sicurezza.
La modernizzazione non ha declassato gli anziani, ha declassato la famiglia. Ha permesso a tutti, giovani e vecchi, uno stile di vita connotato da maggior autonomia e maggior libertà, compresa quella di essere meno attenti alle altre generazioni.
Le case di riposo furono create per liberare i letti negli ospedali. E infatti si chiamano case di cura. E questo rimane lo schema usato per affrontare la vecchiaia, quello sanitario.
Nel suo libro Asylums, uscito mezzo secolo fa, il sociologo Erving Goffman notava la somiglianza esistente tra le prigioni e le case di riposo. Al pari dei campi di addestramento militare, degli orfanatrofi e degli ospedali psichiatrici, sono entrambe “Istituzioni totali”, luoghi in gran parte isolati dal più ampio contesto sociale.
Le probabilità di non finire in casa di riposo sono direttamente collegate al numero di figli di cui si dispone e avere almeno una figlia sembra influire in modo decisivo sulla quantità di aiuto che sarà ricevuta.
La casa è l’unico posto dove le proprie priorità regnano sovrane. A casa tua decidi tu come spendere il tuo tempo, come ripartire il tuo spazio, come gestire i tuoi beni personali. Fuori casa non puoi. È questa perdita di libertà che molte persone temono più di ogni altra cosa.
La gerarchia dei bisogni di Maslow non sempre viene seguita. Gli individui appaiono spesso disposti a sacrificare sicurezza e sopravvivenza in nome di realtà ed ideali che travalicano le loro stesse persone, come la famiglia, la patria o la giustizia.
Man mano che invecchiano le persone interagiscono con un numero minore di persone e si dedicano maggiormente a passare il tempo con i familiari e gli amici più stretti. Hanno più a cuore l’essere che il fare e si concentrano più sul presente che sul futuro.
Il modo in cui cerchiamo di passare il tempo dipende dalla quantità di tempo che percepiamo di avere ancora a disposizione. Quando “la fragilità della vita si accentua”, le mete ed i moventi delle persone nella vita quotidiana cambiano completamente. Ciò che conta è il punto di vista, non l’età.
Chi si sta spegnendo ha bisogno di comodità quotidiane, di compagnia, di essere aiutato a raggiungere i propri modesti traguardi.
Uno dei problemi più spinosi della nostra società rimane quello di capire in che modo un individuo normale possa invecchiare senza dover scegliere tra essere abbandonato a se stesso ed essere istituzionalizzato.
Se non hai una famiglia su cui contare ti ritrovi al massimo con un’esistenza istituzionale, sotto controllo e sotto tutela, una risposta medica a problemi medicalmente irrisolvibili, una vita pensata per essere sicura, ma priva di interesse.
Le tre piaghe della vita nelle case di riposo: noia, solitudine, impotenza.
Tutti noi cerchiamo una ragione di vita situata al di là di noi stessi. Può essere una ragione grande (la famiglia, la patria, una ragione morale) o piccola (badare alla casa, a un cane). Quel che conta è che, attribuendo un valore alla causa e considerandola meritevole dei nostri sacrifici, diamo un senso alla nostra vita.
I professionisti della salute sono interessati al ripristino delle condizioni di salute, non al nutrimento dell’anima. Tuttavia, ed è qui il doloroso paradosso, abbiamo deciso che fossero loro a stabilire come dovevamo vivere i nostri ultimi giorni.
Il semplice fatto di aver bisogno di aiuto nella vita quotidiana secondo molti comporta la necessità di sacrificare la propria autonomia. Dice Ronald Dworkin che invece l’uomo vuole conservare la propria autonomia, la libertà di essere artefice della propria esistenza, quali che siano i limiti e le pene cui dovrà far fronte.
Il terrore dell’infermità e della vecchiaia è anche il terrore dell’isolamento. Gli uomini, quando diventano consapevoli della finitudine della propria esistenza, non chiedono grandi cose. Non cercano nuove ricchezze. Non vogliono più potere. Chiedono solo che sia loro consentito di continuare a plasmare la storia del loro essere al mondo: di fare scelte, di mantenere i contatti con il prossimo secondo le proprie priorità.
Se vogliamo migliorare la vita di questi pazienti dobbiamo porre un freno agli imperativi di tipo prettamente medico, e resistere quindi al nostro bisogno di armeggiare, riparare, controllare.
Le persone gravemente ammalate hanno altre preoccupazioni oltre al semplice prolungamento della loro vita. Vogliono evitare di soffrire, stare a più stretto contatto con familiari e amici, mantenere la lucidità mentale, non essere di peso agli altri e riuscire a dare un senso di completezza alla propria esistenza.
Quando crediamo di avere molto più tempo di quello che effettivamente ci resta, l’unico nostro impulso è combattere. Il fatto che stiamo forse accorciando o peggiorando quel poco di vita che ci resta appare quasi privo di rilevanza. Pensiamo di poter tener duro fino a quando i dottori non ci diranno che non c’è più niente da fare. Ma è raro che i dottori non abbiano più niente da fare.
I pazienti che hanno la possibilità di discutere con i propri medici le preferenze relative all’ultimo periodo di vita hanno maggiori probabilità di morire in pace e con il controllo della situazione, e anche di risparmiare angosce ai familiari.
La morale che se ne può trarre è quasi zen: si vive più a lungo solo quando si smette di cercare di vivere più a lungo.
Usare la parole giuste è importante. Non bisogna dire: “Mi spiace che le cose siano andate così”, ma meglio dire “Vorrei che la situazione fosse diversa”. Non bisogna chiedere “Cosa vuole prima di morire?” ma piuttosto “Se le restasse poco tempo, cosa sarebbe per lei più importante?”
Occorre chiedersi qual è il ruolo della medicina. Esiste un tipo di relazione medico-paziente chiamato “interpretativa” in cui il ruolo del dottore è quello di aiutare i pazienti a stabilire ciò che vogliono. I dottori interpretativi chiedono “Che cos’è più importante per lei? Quali sono le sue preoccupazioni?” È un processo decisionale condiviso.
Quando i medici specializzati in cure palliative devono discutere coi i pazienti di brutte notizie, chiedono, rispondono, chiedono: chiedono cosa volte sapere, poi ve lo dicono, dopo di che chiedono cosa vate capito di quello che vi hanno detto.
Esempio: inizia dicendo “Sono preoccupato” e continua “Che idea ti sei fatto di ciò che ti sta succedendo?” “Solo oggi comincio a riconoscere in quale misura il rendersi conto che il proprio tempo sta per finire possa essere un dono.”
Cosa significa avere autonomia? Può succedere di non poter controllare le circostanze della vita, ma riuscire ad essere l’autore della propria vita significa poter controllare quel che si fa con le circostanze che ci vengono date.
Nel 380 a.C. Platone scrisse un dialogo, il Lachete, nel quale Socrate e due generali ateniesi cercavano di rispondere ad una domanda apparentemente semplice: che cos’è il coraggio? Forse il coraggio è una “perseveranza intelligente”. “Il coraggio è la forza di fronte alla conoscenza di ciò che si deve temere e di ciò che si deve osare. E la saggezza è una forza prudente.”
Nella vecchiaia e nella malattia sono necessari due tipi di coraggio. Il primo è quello di affrontare la realtà della mortalità. Voler sapere ciò che deve essere temuto e ciò che deve essere sperato. Ed è già molto difficile. Il secondo tipo di coraggio è quello di agire in base alla verità che abbiamo scoperto. “Ma la vera sfida, sono arrivato a capire, è un’altra. È decidere se a dover prevalere sono le proprie paure o le proprie speranze.”
La nostra più dolorosa incapacità di trattare gli infermi e gli anziani è l’incapacità di riconoscere che essi hanno anche altre priorità oltre alla sicurezza e al prolungamento della vita; che per dare significato alla vita è fondamentale poter plasmare la propria storia.
“Le persone vogliono condividere i ricordi, trasmettere saggezze e oggetti personali, definire le relazioni, far pace con Dio, e assicurarsi che chi resta non abbia problemi. Vogliono concludere la loro storia a modo loro. Come è stato osservato, si tratta di uno dei più importanti ruoli della vita, sia per chi lo ricopre sia per chi resta.”
Ci siamo sbagliati a proposito del lavoro del medico. Pensiamo che sia assicurare salute e sopravvivenza. In realtà è qualcosa di più vasto. È permettere il benessere. E il benessere ha a che fare con le ragioni per cui uno desidera essere vivo. Ogni sforzo di medici e assistenti e familiari è giustificato solo se serve i più vasti scopi della vita di una persona.
(brani tratti da: Atul Gawande – Essere mortale, ed. Einaudi, 2016)